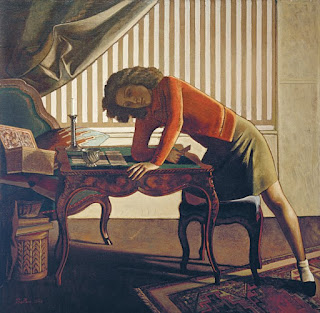Può capitare che un libro – su
cui avevi riposto interesse ed aspettative, anche in forza dei giudizi positivi
espressi dalla critica – ti lasci, a lettura terminata, una sorta di amaro
in bocca. E non ti sai spiegare il perché, nonostante lo stile della scrittura
sia altissimo. Arrivi quasi con fatica all’ultima pagina, magari saltandone
anche qualcuna, e ti accorgi che la storia che hai appena finito di leggere non
ti ha soddisfatto del tutto. Hai come la sensazione di non averlo letto con la
dovuta attenzione, di non essere riuscito ad immedesimarti nella psicologia dei
personaggi, interrompendo troppe volte la lettura oppure di avere scelto il
momento forse meno adatto per interiorizzarlo. E quell’amaro in bocca ti fa
quasi pensare ad una tua evidente sconfitta, ad una tua incapacità di
comprenderlo nella sua intima essenza. E allora – quasi a voler confermare la
qualità letteraria del romanzo – ti assale e ti tormenta un strano pensiero che
ti spinge a rileggere il libro. Tali sono state le sensazioni di fronte a “Il
dolore perfetto” di Ugo Riccarelli, uno scrittore piemontese (era nato a Ciriè
in provincia di Torino), morto a Roma nel 2013 a soli 58 anni. Ma sinceramente non
so se avrò di nuovo la voglia di riprenderlo tra le mani, per recuperare ciò
che in questa prima lettura non ho saputo cogliere.
La storia prende le mosse da un
paese del Sud, Sapri. Ci troviamo negli anni immediatamente successivi
all’Unità d’Italia. I “trecento” di Carlo Pisacane erano stati massacrati
proprio da quei contadini che volevano liberare dal dominio borbonico, mentre
il nuovo stato italiano era nato nel nord ma nelle campagne di Sapri -
incontrastato feudo di una classe di notabili avida e prepotente, pronta a
saltare sul carro del vincitore - si manifestava soltanto con i suoi soldati
violenti e con la consueta ingiustizia e sopraffazione. E da questo Sud antico,
arretrato e sfruttato, da questa civiltà contadina arcaica e immobile, emigra
verso il Centro-Nord un giovane maestro, con le sue idee anarchiche che non
riconoscevano autorità né allo Stato, né al Re, né alla Chiesa; un idealista
animato da un utopistico progetto rivoluzionario di rivalsa sociale, convinto
che “anche i cafoni hanno un cervello”.
Approda in Toscana in un piccolo paese (Colle) che apparentemente gli ricorda
la sua Sapri, seppure con le dovute differenze: “i contadini e la povera gente – scrive l’autore - erano povera gente qui come dalle sue parti,
ma i volti erano meno spigolosi, le facce più aperte al sorriso, quasi che la
bellezza del paesaggio (…) avesse mitigato anche i suoi abitanti (…) e fu
colpito dalla gentilezza delle donne. Non che quelle delle sue parti non
fossero gentili, ma mantenevano sempre, in ogni circostanza, un riserbo, quasi
una scontrosità che le isolava in una sorta di mondo a parte…”. Il “Maestro” – verrà chiamato così durante
tutta la narrazione – si innamorerà, in questo ambiente descritto quasi in
maniera fiabesca e idilliaca, di una vedova del posto da cui avrà 5 figli ed ai
quali darà nomi assai simbolici, in linea con le sue idee: Ideale, Mikhail,
Libertà, Bartolo, Cafiero. La vedova Bartoli, con amore e dedizione,
asseconderà le idee del maestro e lo sosterrà anche nei momenti di grande
difficoltà in cui verrà a trovarsi, a seguito delle sue battaglie politiche che
lo costringeranno alla fuga ed all’esilio.
Nel corso degli anni le vicende della
famiglia Bartoli si intrecciano, attraverso amori e matrimoni, con quelle della
famiglia Bertorelli, commercianti di maiali i quali - appassionati di epica e
di Omero - amavano leggere, nelle sere d’inverno accanto al camino, l’Iliade e
l’Odissea e si tramandavano, di generazione in generazione, i nomi degli eroi
dei poemi omerici: Ulisse e Telemaco, Paride e Ganimede, Enea e Didone... Due
famiglie, due modi diversi di vedere la realtà e la vita: idealisti gli
appartenenti alla famiglia del “maestro”, materialisti i commercianti di maiali.
Eppure, nonostante le differenze, i due gruppi familiari riusciranno a trovare
punti d’incontro e di condivisione. E le vicende umane e spirituali di questo
microcosmo, che racchiude matrimoni e nascite, amori struggenti e divisioni
laceranti, si sovrappongono ai drammatici avvenimenti della Storia che vanno dalla
tragica spedizione di Sapri condotta dal Pisacane, fino al secondo dopoguerra,
con le sue rivolte, le sue epidemie, i suoi morti, le sue speranze. Il dolore è
sempre presente nelle pagine del libro; è un sentimento ricorrente, forte e
perfetto, come dice il titolo, un aspetto predominante del racconto che si
esplica nei momenti drammatici dell’esistenza ma anche negli attimi di gioia
del quotidiano. Un dolore perfetto, che abbaglia e che si percepisce non solo quando
la vita lascia il posto alla morte, ma anche quando la vita fa nascere una
nuova vita. Ed è ciò che intuisce Annina, uno dei tanti personaggi del romanzo,
mentre passa dalla vita alla morte: “Appena
qualche attimo prima di morire, appoggiata al nocciolo del giardino, l’Annina
emerse dall’ombra in cui la sua mente si era nascosta da molti anni e, all’improvviso,
in quei brevi istanti che la morte ancora le concesse (…) vide sua madre
partorirla urlando di un dolore che le sembrò perfetto, e solo alla fine, quasi
spiando, scorse la propria testa uscire da quel corpo rosso e gonfio dallo
sforzo, e sentì per l’ultima volta l’odore di viole del suo fratello gemello
che da dentro la pancia la spingeva nel mondo”.