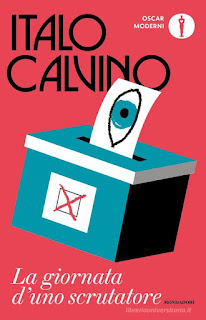Un caminetto acceso, nelle serate invernali, ha
sempre esercitato su di me un fascino straordinario. Una forte attrazione. E’ come
ritornare alla mia infanzia, quando il focolare era il centro della vita
domestica e offriva non solo calore ma anche serenità, rafforzando quello
spirito familiare dello stare insieme. E’ come rivedere le persone care che non
ci sono più. E’ riassaporare sensazioni e odori e sapori e ricordi preziosi che
albergano, indelebili, nella mia memoria.
Il focolare acceso - prima ancora che una fonte
di calore – è per me uno stato d’animo. Una filosofia di vita. E’ riscoprire le
cose essenziali della vita. Simbolo di accoglienza e di tradizioni, è una sorgente
di piacere che riscopro ogni qual volta mi ritrovo al paese nelle feste di fine
anno. Mi piace stare accovacciato su una vecchia seggiola, godermi quella beatitudine
nascosta tra le fiamme che scoppiettano e che sembrano gesticolare, parlandomi dell’anno
che sta per finire e consigliandomi su quello che verrà. In un’epoca dominata
dalla tecnologia sempre più invasiva, il focolare mi riporta alle origini e
assurge quasi a simbolo di nume tutelare della casa. Una presenza sacrale che
unisce e invoglia a raccontarsi. Ma anche una presenza silenziosa. Manca nella nostra società, nelle nostre
case sempre più moderne e tecnologiche, un punto di riferimento così antico e
familiare, oggi sostituito da strumenti digitali che annullano il silenzio,
anche quando sono spenti, e illudono e allontanano le persone dalla realtà
circostante. Andando con la mente alla mitologia greca, è come se Estia, la dea
del focolare che vigilava sulla casa, venisse sostituita dal dio Prometeo,
l’inventore della tecnica che aveva rubato il fuoco agli dei per darlo agli
uomini.
Il Natale è alle porte ed io mi sono già
rifugiato nella mia casetta nativa, nel Cilento. “Non ho voglia di tuffarmi
in un gomitolo di strade (mi vengono in mente i versi di una
indimenticabile poesia di Ungaretti) lasciatemi così come una cosa posata in
un angolo e dimenticata”. E aspettando che passi questa “tempesta”
consumistica, fatta di luminarie e panettoni e regali e cenoni e confusione, me
ne sto accanto al fuoco, a godermi le piccole gioie della vita, a dimenticare rimpianti
e a stemperare malinconie. “Qui non
si sente altro che il caldo buono – faccio ancora miei i versi del poeta – sto
con le quattro capriole di fumo del focolare”. Quanto sarebbe triste e
fredda questa casetta se, dal suo tetto, non salisse il fumo del mio caminetto.
Anche il paese sembrerebbe incompiuto, come un presepe senza pastori, se dai
tetti delle case non svettassero i tanti fantasiosi comignoli che resistono al
peso del tempo.
Accendere il fuoco è un rituale rilassante che
mi concedo tutte le mattine, appena sveglio. Non potrei mai rinunciarvi. Uso
come base di accensione dei fogli di giornale appallottolati, con dei legnetti
molto secchi di facile combustione. Poi aggiungo, man mano che la fiamma
aumenta, della legna più robusta proveniente dalla mia campagna: legna di
quercia, di olmo o di ulivo, legna che sprigiona odori inconfondibili che sanno
di terra e di natura. La mia abilità nell’officiare questa liturgia mattutina
mi conforta. Mi dona serenità. Inondato dal riverbero della fiamma, osservo
estasiato le faville che schizzano di qua e di là, simili a lucciole di antica
memoria, che ridestano i miei ricordi infantili. Da bambino amavo sbucciare i
mandarini e lanciare le scorze nel fuoco: mi piaceva tanto quel profumo che si
sprigionava dai tizzoni ardenti e si diffondeva nell’aria, mentre aumentava
all’improvviso la vampata. E quasi mi intimoriva quel suo “linguaggio”
crepitante. “Quando il fuoco brontola – diceva la buon’anima di mia
nonna - c’è qualcuno che ti pensa”. E chi mai poteva essere? Ecco
allora che la mia fantasia cominciava a galoppare, per dare un nome a quella
voce misteriosa che proveniva dal camino. Un gioco a cui non rinunciavo, invogliato
dalla nonna.
Rinvigorire la fiamma stuzzicando i tizzoni e aggiungendo
nuova legna, che ritiro da una catasta innalzata fuori dalla porta di casa, è
per me un piacevole passatempo. E’ un’arte antica, quella di accatastare la legna. Ha una sua bellezza, un
suo fascino misterioso. E’ un po' come costruire un muretto a secco, vale la
stessa tecnica: impilare i ceppi di misure diverse, uno sopra l’altro, al posto
delle pietre. E l’opera è bell’e fatta! A volte è così perfetta che, nel
prelevare i tronchetti da ardere, provo quasi un senso di dispiace doverla smantellare,
quella catasta.
La felicità è stare accanto al focolare nelle
fredde serate di fine anno: è come stare in piacevole compagnia di un amico
fidato, che ti parla e non ti fa sentire mai solo. Mi vengono in mente le
preziose parole che Giovanni Verga scriveva in una sua novella che si intitola
“Nedda”, parole che riscaldano come quel focolare che raccontano e ti
trasportano in un mondo che non c’è più:
“Il focolare domestico era
sempre ai miei occhi una figura rettorica, buona per incorniciarvi gli affetti
più miti e sereni, come il raggio di luna per baciare le chiome bionde; ma
sorridevo allorquando sentivo dirmi che il fuoco del camino è quasi un amico.
Sembrava in verità un amico troppo necessario, a volte uggioso e dispotico, che
a poco a poco avrebbe voluto prendervi per le mani o per i piedi, e tirarvi
dentro il suo antro affumicato, per baciarvi alla maniera di Giuda. Non
conoscevo il passatempo di stuzzicare la legna, né la voluttà di sentirsi
inondare dal riverbero della fiamma; non comprendevo il linguaggio del
cepperello che scoppietta dispettoso, o brontola fiammeggiando; non avevo
l’occhio assuefatto ai bizzarri disegni delle scintille correnti come lucciole
sui tizzoni anneriti, alle fantastiche figure che assume la legna
carbonizzandosi, alle mille gradazioni di chiaroscuro della fiamma azzurra e
rossa che lambisce quasi timida, accarezza graziosamente, per divampare con
sfacciata petulanza. Quando mi fui iniziato ai misteri delle molle e del
soffietto, m’innamorai con trasporto della voluttuosa pigrizia del caminetto.
Io lascio il mio corpo su quella poltroncina, accanto al fuoco, come vi
lascerei un abito, abbandonando alla fiamma la cura di far circolare più caldo
il mio sangue e di far battere più rapido il mio cuore; e incaricando le
faville fuggenti, che folleggiano come farfalle innamorate, di farmi tenere gli
occhi aperti, e di far errare capricciosamente del pari i miei pensieri…”


.jpg)