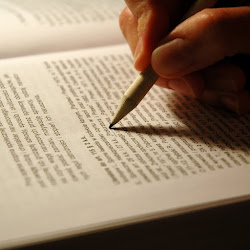Marcello Veneziani è un noto
giornalista, scrittore e filosofo, considerato tra gli intellettuali più
autorevoli della destra italiana. Non ha, però, la visibilità mediatica di un
Cacciari o di un Galimberti. Mi è capitato di ascoltarlo e, soprattutto di
leggerlo, in questi ultimi tempi, e devo dire che - anche se non sempre
condivido tutto quello che dice e che scrive – apprezzo molto il suo linguaggio,
per niente involuto. Credo che non bisogna cadere in quel pregiudizio, duro a
morire, secondo il quale solo chi ha le tue stesse idee merita importanza e
riconoscimento. D’altra parte, per giudicare un autore si deve sempre avere
l’onestà e lo spirito critico di distinguere le sue posizioni politiche dalla
sua prosa e dall’impronta che lascia nel lettore, prima ancora che nelle pagine della letteratura.
Veneziani è nato a Bisceglie in
Puglia, è una persona pacata, dallo sguardo malinconico, che ama la lentezza e
critica duramente la tirannia della tecnica. Riesce a comunicare molto bene il
suo pensiero, un “pensiero mediterraneo” – per usare una sua espressione – e si
confronta con il presente e la tradizione, con la filosofia e la religione, con
il mito e la storia. E nell’epoca globale in cui viviamo, caratterizzata da un
pensiero unico e allineato, voci come la sua sono davvero confortanti.
Ho letto il suo ultimo libro,
pubblicato da Marsilio, che si intitola “Senza eredi” con sottotitolo “Ritratti
di maestri veri, presunti e controversi in un’epoca che li cancella”. Nella
storia dell’umanità – sostiene lo scrittore pugliese – questa “è la prima ad
avvertire, come Luigi XV, che dopo di noi verrà il diluvio, che finirà con noi
il mondo in cui viviamo”.
In ogni campo sembra aver valore
positivo solo ciò che è nuovo, destinato a far dimenticare ogni cosa
precedente. Sono rinnegati i maestri, la loro opera, le loro lezioni di vita.
Non hanno nulla da insegnare perché arrivano da un tempo arretrato rispetto al
nostro, con modi di vedere e di pensare e di agire superati. Questa perdita del
“filo ereditario” si manifesta – secondo Veneziani – in tre forme
intrecciate: in primis, non esiste più, tra le generazioni, un mondo comune di
valori, di saperi e di tradizioni che uniscono, pur nella diversità anagrafica;
non si parla lo stesso linguaggio per intendersi e comunicare; non c’è curiosità
e interesse per il passato e riconoscenza per i grandi maestri che ci hanno
preceduti. Tutto diventa obsoleto in fretta, tutto si automatizza e va
sostituito. E il passato, quando non è esecrato, va cancellato, rimosso. In una
società come la nostra che non conosce eredi e “non si riconosce erede di
niente e di nessuno”, parlare di maestri, dice Veneziani, è un’impresa
davvero ardita. Al loro posto pontificano gli influencer, i veri manipolatori
delle coscienze che “seducono e conformano, agendo sul linguaggio,
sull’immaginario globale e sul narcisismo individuale di massa”. Un’epoca
senza maestri e senza eredi è anche un’epoca di solitudine di massa: il destino
paradossale di un tempo iperconnesso che offre a ciascuno la possibilità di eleggersi,
attraverso i social, maestri di se stessi.
Con questo suo libro, Marcello Veneziani ci presenta una
raccolta di settanta brevi ritratti “non convenzionali, in vari casi
sconvenienti” di maestri “veri, presunti o controversi, grandi e
piccini”. Sono delle succinte biografie di scrittori, poeti, grandi giornalisti,
filosofi - del passato come del presente - accomunati dallo stesso avverso destino: non hanno eredi. Da Giordano Bruno,
che orientò lo sguardo del suo pensiero all’infinito, a Giambattista Vico che
lo rivolse, invece, all’eternità; da Manzoni che si affidò alla Provvidenza, a
Verga che confidò nel Fato; da Baudelaire, poeta dionisiaco dell’ebrezza a
D’Annunzio, il poeta soldato, l’esteta armato; da Proust, che guardò il mondo
dallo “specchietto retrovisore” a Kafka, che si sentì come un insetto
schiacciato dalla vita e dal potere; da Tomasi di Lampedusa e il suo
trasformismo a Moravia, il cantore della borghesia romana; da Pascal a
Leopardi, da Nietzsche a Kant, da Manganelli a Marchesi, da Camilleri a De
Crescenzo, da Bocca a Scalfari a Sartori…quanti maestri senza eredi.
Ma noi – scrive Veneziani nel
suo libro - “Non ci rassegniamo e ripetiamo con il drammaturgo
austriaco Franza Grillparzer: “Se il mio tempo mi vuole avversare, lo lascio
fare tranquillamente. Io sono venuto da altri tempi e in altri tempi spero di
andare”. Nonostante tutto, continueremo a sentirci eredi di autori e tradizioni
e a onorare i maestri, i padri, i fratelli maggiori. E, se saremo soli, vuol
dire che saremo in compagnia degli dei, degli assenti, degli invisibili”